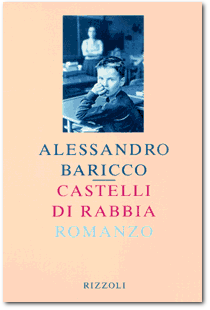- Home
- Il sito
- City
- Percorsi
- Dintorni
- Panorami
- Chi scrive
da castelli di rabbia
Brani da Castelli di rabbia
Una sporcheria dolcissima
Sui treni, per salvarsi, per fermare la perversa rotazione di quel mondo che li martellava di là dal vetro, e per schivare la paura, e per non farsi risucchiare dalla vertigine della velocità che certo doveva continuamente bussargli nel cervello quanto meno nella forma di quel mondo che strisciava di là dal vetro in forme mai viste prima, meravigliose certo, ma impossibili perché il solo concederglisi per un attimo istantaneamente rimetteva in corsa la paura, e di conseguenza quell'ansia densa e informe che cristallizzata in pensiero si rivelava a tutti gli effetti nient'altro che il sordo pensiero della morte - sui treni, per salvarsi, presero l'abitudine di consegnarsi a un gesto meticoloso, una prassi peraltro consigliata dagli stessi medici e da insigni studiosi, una minuscola strategia di difesa, ovvia ma geniale, un piccolo gesto esatto, e splendido.
Sui treni, per salvarsi, leggevano. Linimento perfetto. La fissa esattezza della scrittura come sutura di un terrore. L'occhio che trova nei minuscoli tornanti dettati dalle righe la nitida scorciatoia per sfuggire all'indistinto flusso di immagini imposto dal finestrino. Vendevano, nelle stazioni, delle apposite lampade, lampade per la lettura. Si reggevano con una mano, descrivevano un intimo cono di luce da fissare sulla pagina aperta. Bisogna immaginarselo. Un treno in corsa furibonda su due lame di ferro, e dentro il treno un angolo di magica immobilità ritagliato minuziosamente dal compasso di una fiammella. La velocità del treno e la fissità del libro illuminato. L'eternamente cangiante multiformità del mondo intorno e l'impietrito microcosmo di un occhio che legge. Come un nòcciolo di silenzio nel cuore di un boato. Non fosse storia vera, vera storia, si potrebbe pensare: non è che la bellezza di un'esatta metafora. Nel senso che forse, . sempre, e per tutti, altro non è mai, léggere, che fissare un punto per non essere sedotti, e rovinati, dall'incontrollabile strisciare via del mondo. Non si leggerebbe, nulla, se non fosse per paura. O per rimandare la tentazione di un rovinoso desiderio a cui, si sa, non si saprà resistere. Si legge per non alzare lo sguardo verso il finestrino, questa è la verità. Un libro aperto è sempre la certificazione della presenza di un vile – gli occhi inchiodati su quelle righe per non farsi rubare lo sguardo dal bruciore del mondo – le parole che a una ad una stringono il fragore del mondo in un imbuto opaco fino a farlo colare in formine di vetro che chiamano libri – la più raffinata delle ritirate, questa è la verità. Una sporcheria. Però: dolcissima. Questo è importante, e sempre bisognerà ricordarlo, e tramandarlo, di volta in volta, da malato a malato, come un segreto, il segreto, che non sfumi mai nella rinuncia di nessuno o nella forza di nessuno, che sopravviva sempre nella memoria di almeno un'anima sfinita e lì suoni come un verdetto capace di far tacere chicchessia: léggere è una sporcheria dolcissima. Chi può capire qualcosa della dolcezza se non ha mai chinato la propria vita, tutta quanta, sulla prima riga della prima pagina di un libro? No, quella è la sola e più dolce custodia di ogni paura – un libro che inizia. Così che, insieme a migliaia di altre cose, cappelli, animali, ambizioni, valigie, soldi, lettere d’amore, malattie, bottiglie armi, ricordi, stivali, occhiali, pellicce, risate, sguardi, tristezze, famiglie, giocattoli, sottovesti, specchi, odori, lacrime, guanti, rumori – insieme a quelle migliaia di cose che già sollevavano da terra e lanciate, vano a velocità prodigiosa quei treni che rigavano avanti e indietro il mondo come ferite fumanti si portavano dentro anche la solitudine impagabile di quel segreto: l'arte di leggere. Tutti quei libri aperti, infiniti libri aperti, come finestrelle aperte sul dentro del mondo, seminate su un proiettile che offriva allo sguardo, solo si avesse avuto il coraggio di alzarlo, lo sfavillante spettacolo del mondo di fuori. Il dentro del mondo e il mondo di fuori. Il dentro del mondo e il mondo di fuori. Il dentro del mondo e il mondo di fuori. Il dentro del mondo e il mondo di fuori. Alla fine finisce così, che in un modo o nell'altro, ancora una volta, si sceglie il dentro del mondo, mentre tutt'intorno ti sferraglia la tentazione di farla finita una buona volta e di rischiare a vederlo questo mondo di fuori, cosa sarà mai possibile che sia davvero così pauroso, possibile che non se ne andrà mai questa vigliacca paura di morire, di morire, morire, morire, morire, morire, morire?
Quinnipak
Me l'ha insegnata Tool questa cosa.
Andare a Quinnipak, dormire a Quinnipak, fuggire a Quinnipak.
Ogni tanto gli chiedevo "Dove sei stato, che tutti ti cercavano?".
E lui diceva "Ho fatto un salto a Quinnipak". É una specie di gioco.
Serve quando hai lo schifo addosso, che proprio non c'è verso di togliertelo.
Allora ti rannicchi da qualche parte, chiudi gli occhi, e inizi ad inventarti delle storie.
Quel che ti viene.
Ma lo devi fare bene.
Con tutti i particolari.
E quello che la gente dice, e i colori, e i suoni.
Tutto.
E lo schifo a poco a poco se ne va.
Poi torna, è ovvio, ma intanto per un po' l'hai fregato.
La prima volta che lo beccarono, Tool, lo portarono in galera su un furgone.
C'aveva una finestrella.
Tool aveva paura della galera.
Guardava fuori e si sentiva morire.
Passarono un incrocio e sul bordo della strada c'era una freccia che indicava la via per un paese. É lì che Tool lesse quel nome: Quinnipak.
Per uno che sta andando in galera, vedere una freccia che porta altrove dev'essere come guardare in faccia l'infinito.
Qualsiasi cosa ci fosse laggiù, era comunque vita, e non galera.
Così quel nome gli rimase appiccicato in testa.